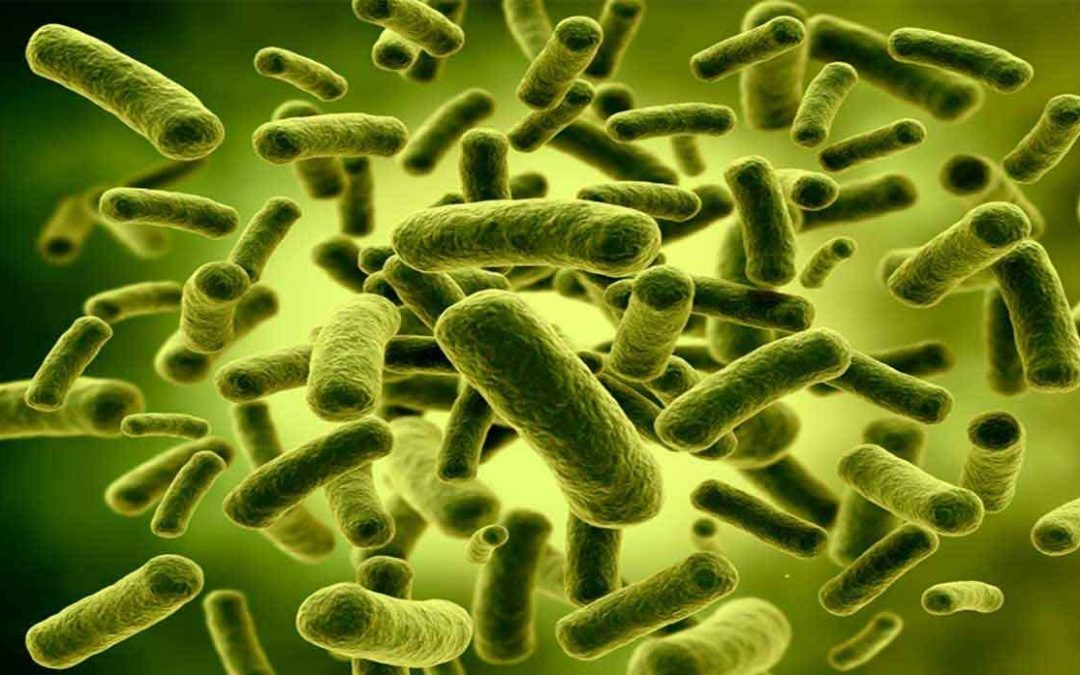Mar 19, 2020 | ALIMENTAZIONE E SALUTE, MEDICINA FUNZIONALE, OMEOPATIA
In questa sede desidero focalizzare l’attenzione sulla composizione del microbiota intestinale in funzione del sonno e valutare dalla letteratura se i due elementi, sonno e microbiota, possono influenzarsi reciprocamente e se un eventuale disequilibrio può avere effetti sulla salute.
Le modalità di collegamento ed influenza tra microbiota e cervello sono quattro:
- la prima via è quella della regolazione immunitaria.
I batteri intestinali influenzano la funzione cerebrale attraverso l’interazione con le cellule immunitarie che regolano la produzione di citochine, di prostaglandine, in particolare PGE2, e di altri micro-fattori immunitari.
- la seconda via è quella neuroendocrina.
La mucosa intestinale contiene almeno 20 tipi di cellule entero-endocrine. tanto da far considerare l’intestino come l’organo endocrino più esteso dell’organismo.
Il microbiota intestinale può influenzare l’Asse Ipotalamo-Ipofisi-Surrene ed il collegamento con il Sistema Nervoso Centrale, sia- attraverso questo- la secrezione di cortisolo, triptofano e serotonina.
- la terza via è quella del nervo vago.
Il microbiota intestinale può influenzare attraverso i recettori neuronali situati nel Plesso Mioenterico e da qui stimolare informazioni ascendenti mediate dal nervo vago.
- la quarta via è quella dell’assorbimento delle sostanze tossiche.
Direttamente o indirettamente i batteri componenti il microbioma intestinale producono sostanze che, se in eccesso o se favorite dalla rottura delle giunzioni serrate, riescono ad attraversare la barriera enterica, entrare in circolo e raggiungere il cervello o perché autorizzate al passaggio attraverso la Barriera ematoencefalica o perchè questa, a causa dell’infiammazione silente e persistente, è diventata permeabile alle tossine.
Queste quattro vie di comunicazione tra intestino e cervello assumono un’importanza fondamentale per la salute, soprattutto se correlate allo stile di vita.
I batteri che popolano l’intestino hanno evidenziato ritmi circadiani sia nella composizione della popolazione delle colonie sia sull’attività funzionale.
Alcuni lavori hanno evidenziato che Clostridi, Lattobacilli e Bacterioidi, che rappresentano circa il 60 % dell’intero microbiota intestinale, mostrano fluttuazioni diurne significative.
Bacteroides e Firmicutes, in particolare, hanno dimostrato variazioni cicliche correlate non soltanto all’assunzione ritmica del cibo e più in generale alla dieta, ma anche alle funzioni scandite dall’orologio biologico dell’ospite.
In diverse occasioni è stato dimostrato che il mancato rispetto del ritmo sonno/veglia in funzione della presenza di luce naturale e dell’espressione dei geni orologio può interferire in modo bilaterale con la composizione del microbiota intestinale. Ciò è particolarmente evidente nelle persone che per ragioni lavorative o, per stile di vita sono costrette ad attività notturne o comunque a non rispettare il ritmo sonno/veglia.
La perturbazione dell’Asse cervello-microbiota sono state associate a disturbi gastroenterici, depressione, malattia di Parkinson, ansia e riduzione delle capacità cognitive.
Poiché diverse patologie sono correlate alla circadianità del Sistema Neuroendocrino, è possibile che vi sia una correlazione tra malattia, ritmo sonno/veglia e composizione del microbiota intestinale.
Uno studio ha dimostrato che la mutazione dei geni orologio (geni che regolano i ritmi) all’interno di una popolazione di ratti provava l’alterazione del microbiota e che questa viene esacerbata da stimoli dietetici. Questo risultato evidenzia che la popolazione intestinale svolge un ruolo cruciale nel mantenimento della normale espressione dei geni dell’ ospite.
In questa rubrica ho già scritto circa l’importanza del sonno anche per ciò che riguarda il drenaggio tossinico cerebrale. In particolare, è stato evidenziato come il Sistema Glinfatico operi durante le ore notturne quando la produzione di noradrenalina diminuisce, fino quasi ad esaurirsi.
Questo neurotrasmettitore ad attività simil-ormonale prodotto dal surrene è in stretta connessione con lo stress che, tra l’altro, è in grado di provocare disturbi della qualità del sonno.
E’ possibile correlare questi due elementi con la composizione del microbiota intestinale in un unicum funzionale in cui ognuno di questi tre attori può influenzare in maniera fisiologica o patologica lo stato di salute dell’individuo. Una disbiosi intestinale può essere causa di stress e/o di alterazione della qualità del sonno.
Ciascuno di questi elementi può essere il primum movens di disturbi che riguardano gli altri due.
Tutto questo si inserisce in un contesto di valutazione dello stile di vita in generale, non solo alimentare, allo scopo di coordinare le diverse componenti dello stile di vita in funzione del recupero della salute.
I punti da prendere in considerazione sono:
- Qualità del sonno. Occorre indicare l’importanza di un sonno ristoratore che duri almeno 6 ore (non più di 9) in un ambiente aerato, buio, privo di influenze elettromagnetiche.
- Ritmo e qualità dei pasti. Bisogna focalizzare l’attenzione sul ritmo dei pasti che, in particolare, rispetti le pause tra un pasto e l’altro e che preveda una cena leggera in funzione proprio della qualità del sonno.
- Gestione dello stress. Inserire pause quotidiane di relax, meditazione, lettura, preghiera ecc. in modo da ridurre al massimo l’esposizione ai momenti stressogeni.
- Attività fisica. Si rileva uno strumento indispensabile sia per l’eliminazione delle tossine metaboliche sia per la produzione di endorfine ad azione antistress.
Da La Medicina Biologica n. 163
Dott. Mauro Piccini
.

Mar 12, 2020 | ALIMENTAZIONE E SALUTE, MEDICINA FUNZIONALE, OMEOPATIA
La vitamina C è in grado di contrastare i processi di ossidazione che avvengono nell’organismo e che sono strettamente correlati con l’invecchiamento e con le malattie provocate da virus e batteri.
La vitamina C (acido ascorbico o ascorbato, nel caso in cui ci si riferisca al sale sodico derivato dall’acido) è, com’è noto, un nutriente essenziale per l’organismo dell’uomo che, contrariamente alla stragrande maggioranza degli altri mammiferi, non essendo in grado di sintetizzarla per proprio conto, deve garantirsene l’apporto mediante l’alimentazione.
Quali sono le funzioni della vitamina C?
Contenuta in minime quantità negli agrumi, nella frutta e in molti vegetali, e in maggiori quantità in alcuni frutti “esotici”, la vitamina C assunta con gli alimenti, viene solo in piccola parte assorbita per svolgere le sue funzioni, che sono molto complesse e ancora non del tutto chiarite, ma che, a grandi linee, si possono distinguere in:
A) funzione enzimatica o “antiossidante” o “fisiologica”. La vitamina C, è il coenzima di almeno otto enzimi fondamentali per le cellule dell’organismo. In questo ruolo è coinvolta nel metabolismo dei neurotrasmettitori, dei lipidi e del collagene e, più in generale, il suo effetto antiossidante protegge l’organismo dagli effetti tossici dei radicali dell’ossigeno, che causano danni alle strutture cellulari determinando una vasta gamma di patologie, che spaziano da raffreddore comune alle malattie neurodegenerative, cardiovascolari e neoplastiche;
B) funzione pro-ossidante o “farmacologica”, che, in vitro, si estrinseca con uno straordinario effetto tossico, specifico e selettivo, sulle cellule tumorali.
Vitamina C: scarso interesse per una molecola non brevettabile
Di fatto, le funzioni della vitamina C sono molteplici, complesse e, purtroppo, non ancora definitivamente chiarite, dato lo scarso interesse della “comunità scientifica” per questa molecola, dai costi molto bassi e non brevettabile.
Contrariamente a quanto tramandatoci dalla tradizione della Medicina moderna, questa sorprendente molecola è, al tempo stesso, “riducente” e, “ossidante”, proprietà che ci consente di inquadrarla nel più ampio gruppo di sostanze definite “redox” (dalla combinazione dei termini inglesi “reducing” e “oxidating”).
Come tale, la vitamina C, è in grado da un lato di contrastare i processi di ossidazione che avvengono nell’organismo e che sono strettamente correlati con l’invecchiamento e la malattia (incluso il cancro) accentuando i processi ossidativi all’interno della cellula tumorale che, diversamente da quella normale, non possiede meccanismi di difesa efficienti contro i processi di ossidazione.
Illustri scienziati, come Irwin Stone, Linus Pauling, Albert Szent-Gyӧrgy e moltissimi altri, raccomandavano l’uso quotidiano di dosi massicce di Vitamina C, per prevenire tutte le malattie e garantire uno stato di salute ottimale; ma, da oltre settant’ anni, continuiamo ad ignorare questo consiglio!
Dott. Mauro Piccini
https://www.scienzaeconoscenza.it/
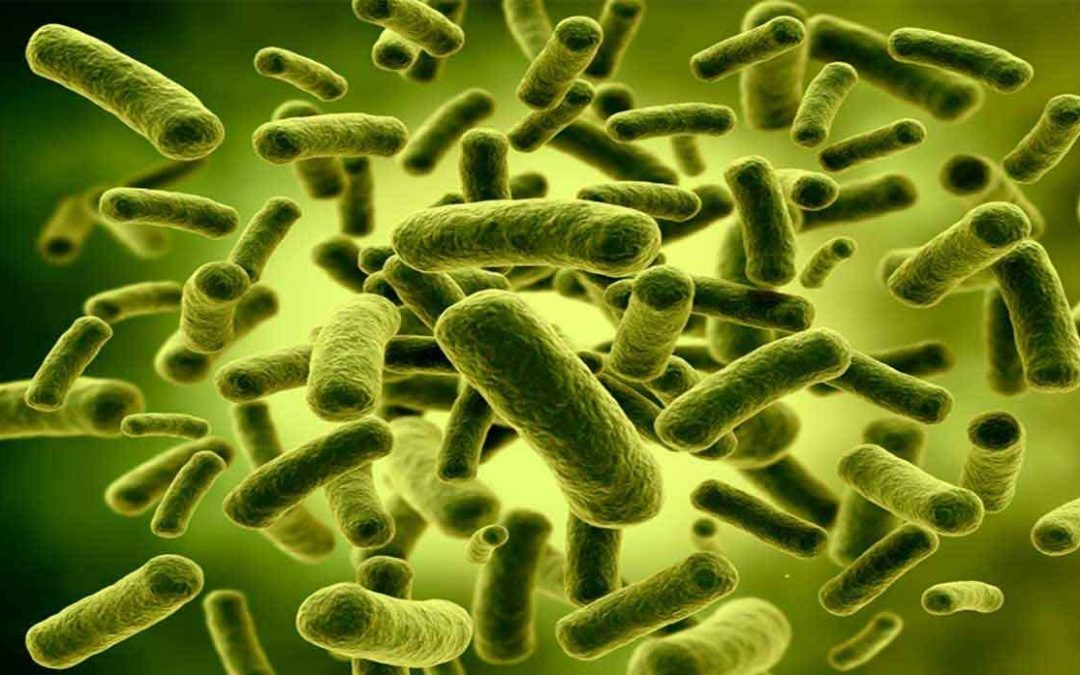
Feb 11, 2020 | ALIMENTAZIONE E SALUTE, MEDICINA FUNZIONALE, OMEOPATIA
Occhio alle informazioni on line sui probiotici: nella maggior parte dei casi sono di carattere commerciale, derivano da fonti poco affidabili, nascondono gli effetti collaterali e promuovono impieghi non supportati da dati scientifici sufficienti.
L’allarme giunge dalle colonne di Frontiers in medicine per voce di un gruppo di ricercatori guidati dall’italiano Pietro Ghezzi che, dopo anni di lavoro all’Istituto Mario Negri di Milano, dal 2008 insegna alla Brighton and Sussex medical school in Inghilterra.
Alla luce del grande interesse che suscita l’argomento e della mole di dati circolanti, Ghezzi e colleghi hanno deciso di valutare le informazioni a cui il pubblico è esposto in caso di ricerche online.
Sono state prese in esame le prime 150 pagine web risultanti da una ricerca su Google con la parola chiave probiotici. Diversi i criteri di valutazione. Innanzitutto, il profilo della fonte (commerciale, istituzionale, giornalistico-informativa, professionale e così via). Poi il cosiddetto punteggio Jama (Journal of the american medical association) basato su: presenza di firma/autore, data di pubblicazione e aggiornamento, indicazione del proprietario del sito e citazione delle referenze bibliografiche. E, ancora, presenza dell’HONcode, una certifcazione terza del sito basata su elementi quali, per esempio, autorevolezza, trasparenza, protezione dei dati, citazione delle fonti. Infine, gli autori annotavano se venivano indicate le specie dei microrganismi citati e se l’informazione fosse completa in termini di potenziali benefici ed effetti collaterali. Le evidenze scientifiche dei benefici promessi sono state verificate usando come riferimento la Cochrane library.
I risultati hanno evidenziato come soltanto il 10% delle pagine web soddisfaceva tutti i criteri di valutazione, solo il 40% riportava informazioni prudenti sui benefici, solo il 35% aveva riferimenti bibliografici e solo il 25% menzionava potenziali effetti collaterali.
“Tali dati ci hanno portato a diverse conclusioni” sottolineano gli autori. “Innanzitutto, le tipologie più frequenti di pagine web restituite da Google sono di carattere commerciale. Queste, poi, forniscono mediamente le informazioni meno affidabili e molti dei benefici dichiarati non sono supportati da prove scientifiche. In molti casi addirittura i risultati di ricerche sui topi sono stati utilizzati per sostenere affermazioni sui benefici dei probiotici nell’uomo”.
Non solo brutte notizie, però. Infatti, la cosiddetta Top10, ovvero i primi dieci risultati della ricerca on line, che poi sono quelli su cui si sofferma la maggior parte delle nostre scelte, è risultata quella con il giudizio qualitativo migliore, segno che Google ha impostato criteri rigorosi al suo algoritmo per la classificazione dei siti.
Così conclude Ghezzi: “E’ un bene che Google abbia sviluppato nel tempo parametri severi per valutare i siti web relativi alla salute. Ciononostante, però, dovremmo sempre chiederci da dove provengono le informazioni che stiamo ricevendo. Google dà la priorità alle pagine web contenenti le informazioni più complete e scientificamente affidabili sui probiotici e questi hanno un posizionamento più elevato rispetto ai siti web commerciali. Tuttavia, il fatto che vi sia una così grande quantità di informazioni orientate al mercato risulta un problema laddove i consumatori sono invece alla ricerca di risposte trasparenti e non condizionate”.
http://www.nutrientiesupplementi.it/index.php/attualita/item/713-le-trappole-del-web-nell-informazione-sui-probiotici
Dott. Mauro Piccini

Gen 9, 2020 | ALIMENTAZIONE E SALUTE, MEDICINA FUNZIONALE, OMEOPATIA, PILLOLE DI RIFLESSIONE
Lo stress uccide il sistema immunitario
Lo stress influisce su molte funzioni del sistema immunitario e può ridurne l’efficacia in modo determinante. Gli effetti sono davvero pericolosi. Ce lo spiega Greta Manoni in questo articolo.
La relazione tra stress e sistema immunitario è stata considerata per decenni.
L’atteggiamento prevalente tra l’associazione di stress e la risposta del sistema immunitario è stato quello secondo cui le persone sotto stress hanno maggiori probabilità di avere un sistema immunitario compromesso e, di conseguenza, soffrono di malattie più frequentemente.
Oggi, dopo 30 anni di ricerca, è un’evidenza dimostrata che gli eventi mediati dal cervello (come lo stress psicologico e la depressione) possono alterare la funzione del sistema immunitario periferico; e che viceversa alterazioni del sistema immunitario periferico (come quelle che si verificano durante una malattia) possono influenzare il cervello determinando modificazioni dell’umore, stati d’ansia e alterazioni cognitive (Schwartz-Nemeroff).
L’immunità è un requisito della vita stessa: anche gli organismi più semplici dimostrano un’attività immune, in accordo con l’ipotesi che l’immunità sia comparsa precocemente nella scala evolutiva sulla terra. Esiste un’immunità innata aspecifica rapida che inizia dalla cute e dalle mucose del tratto gastrointestinale e respiratorio, e costituisce una barriera fisica e chimica all’invasione degli agenti patogeni esterni. Risposte immunitarie innate utilizzano cellule effettrici come i fagociti (macrofagi, neutrofili), cellule natural killer, mediatori solubili (complementi, proteine di fase acuta), citochine (tumor necrosis factor-a, interleuchina-1A e B, interleuchina-6).
La risposta immediata aspecifica mette in moto col tempo la formazione di una risposta immunitaria acquisita, che implica la formazione di una memoria per i molteplici fattori patogeni; la risposta immunitaria acquisita è più specifica ma più lenta. Essa consiste in risposte cellulari (linfociti T-helper 1, linfociti T citotossici, interleuchine-2. interleuchine-12, interferone-gamma) e in risposte umorali (linfociti T-helper 2, linfociti B, anticorpi, interleuchina 4, interleuchina 10).
Il sistema immunitario può essere condizionato dallo stress patologico
Negli anni 70, alcuni ricercatori hanno scoperto che il sistema immunitario è suscettibile al condizionamento classico pavloviano in risposta a stress psicologico (Ader e Cohen, 1975). Diversi studi hanno dimostrato che i mediatori dello stress (ormoni corticosteroidi), essendo rilasciati dalle ghiandole surrenali direttamente nel circolo sanguigno, sono in grado di agire sul sistema immunitario. I ricercatori hanno evidenziato che gli stress cronici e intensi attivano il sistema immunitario innato e indeboliscono le risposte del sistema acquisito.
Gli effetti per la salute di tali alterazioni immunitarie associate allo stress sono dimostrati in studi che rivelano:
- una correlazione tra stress cronico e aumento della vulnerabilità al comune raffreddore
- ridotta risposta anticorpale alle vaccinazioni
- ritardata guarigione delle ferite e comparsa di herpes zoster
Inoltre lo stress e la depressione sono stati correlati ad un incremento di morbilità e mortalità per malattie infettive come l’HIV e malattie neoplastiche (tumore al seno e melanoma). Lo stress grave può infatti portare a malignità sopprimendo l’attività dei linfociti T citotossici e delle cellule natural killer, e condurre alla crescita di cellule maligne, instabilità genetica ed espansione del tumore.
Lo stress aumenta la noradrenalina, che uccide le nostre difese immunitarie
Altri studi hanno dimostrato che la concentrazione plasmatica di noradrenalina, che aumenta dopo lo stress indotto, ha una relazione inversa con la funzione immunitaria di fagociti e linfociti. Infine dalla letteratura è risultato che anche le catecolamine e gli oppioidi (rilasciati in seguito a stress) hanno proprietà immunosoppressive. Tuttavia, come riportato in precedenza, i glucocorticoidi prodotti per brevi periodi e a moderate dosi possono promuovere realmente certi aspetti delle funzioni immunitarie fisiologiche. Durante lo stress acuto o lieve svolgono un ruolo primario nel limitare un’attivazione infiammatoria eccessiva e prolungata. Questa proprietà si utilizza in medicina per il trattamento delle eccessive reazioni immuni in varie patologie: i glucocorticoidi sono ancora oggi i principali farmaci antinfiammatori.
Da: https://www.igorvitale.org/lo-stress-uccide-il-sistema-immunitario/?fbclid=IwAR0W_EU4BY_oYAOkTlzIKCKjvob9UMTE3TN95FrnHjl7G540q1hROqK_PUA
Dott. Mauro Piccini

Gen 8, 2020 | ALIMENTAZIONE E SALUTE, MEDICINA FUNZIONALE
I prebiotici, che fungono da cibo per i batteri, sono ben noti.
Lo stessa dicasi per il continuo mondo in evoluzione dei probiotici, di cui abbiamo idee piuttosto chiare e consolidate, soprattutto in merito alla loro importanza per la salute generale, non solo quella dell’intestino.
Ora una nuova categoria si affaccia all’orizzonte delle nostre possibilità terapeutiche: I POSTBIOTICI.
Con questo termine sono indicati i prodotti del metabolismo batterico che sono utili all’organismo umano e che possono essere proposti al paziente non più come post-produzione della carica batterica eubiotica somministrata, ma direttamente.
In questo modo si evita il rischio di potenziali, anche se improbabili, reazioni negative per le colonie batteriche proposte e si riduce la possibili di cross-reaction da parte del Sistema Immunitario, non sempre infallibile, in special modo in certe categorie di pazienti.
Acidi grassi a media catena, vitamine, enzimi, prodotti derivati dalla lisi cellulare avrebbero, se somministrati direttamente e non per tramite dei batteri che li producono, effetti molto più diretti ed efficacia maggiore, specie come antinfiammatori, immunomodulanti e nutraceutici in senso stretto.
A proposito di questa ultima voce si ricorda che i nutraceutici sono principi attivi presenti nel cibo o da questo estratti per ottenere una loro maggiore concentrazione con l’integrazione. Atto questo che non è scevro da critiche, in particolare indirizzate verso un loro abuso, un’eccessiva fiducia, una loro presunta scarsa utilità.
Tali critiche si basano sul fatto che, in condizioni normali, tutto ciò di cui abbiamo bisogno per vivere in modo sano e completo è presente nel cibo e che non sono molti gli studi che dimostrano l’effettiva utilità dell’integrazione.
In realtà l’esperienza clinica porta a dire che non è così, almeno per due motivi:
1) i risultati che quotidianamente otteniamo con l’integrazione
2) la conoscenza approfondita sulla scarsa qualità del cibo che si serve in tavola.
L’evento clinico che dovrebbe dare tranquillità e sicurezza circa le possibilità della nutraceutica è rappresentato dagli effetti collaterali dell’uso degli antibiotici. L’utilità dell’antibiotico non può essere messa in discussione, semmai il suo abuso.
Come per tutti i farmaci di origine sintetica occorre mettere in conto alcuni effetti collaterali, auspicabilmente di minore entità rispetto ai benefici. Tra questi la mancata selezione dei ceppi patogeni da eliminare, con conseguente distruzione di parte della flora eubiotica, responsabile di un effetto simbiotico che viene a mancare nel periodo di terapia ed anche successivamente, se non opportunamente ricostruita.
In questa fase entrano nel novero delle possibilità nutraceutiche almeno due categorie: probiotici e vitamine.
I primi ad azione ricostruttiva della flora batterica residente, le seconde in sostituzione della regolare produzione da parte del microbiota intestinale.
A proposito dei probiotici esistono ceppi geneticamente resistenti agli antibiotici, che ne permettono la somministrazione anche durante la terapia.
Per ciò che riguarda le vitamine si tratta di prodotti del metabolismo batterico somministrate tali e quali e non attraverso una selezionata quantità di colonie, rientrando certamente nella nuova categoria dei postbiotici.
E’ bene somministrare fin da subito prodotti ad ampio spettro e di provata efficacia in modo da garantire l’opportuno rifornimento di principi attivi e la regolarità delle funzioni cellulari.
Tratto da La Medicina Biologica n.162
Dott. Mauro Piccini

Dic 13, 2019 | ALIMENTAZIONE E SALUTE, PILLOLE DI RIFLESSIONE
Il 18 novembre è stata celebrata la Giornata Europea, che ha fatto seguito alla Settimana mondiale (18-24 settembre), sull’uso consapevole degli antibiotici. Abbiamo avuto la conferma che in Italia si registrano più di 10.000 decessi ogni anno per infezioni causate da batteri resistenti agli antibiotici sui 33.000 in Europa. Un triste primato, spiegabile con l’uso massivo e inappropriato di questi farmaci: in Europa siamo secondi solo alla Grecia per numero di prescrizioni di antibiotici nelle cure primarie.
Cos’è l’antimicrobico-resistenza?1
La resistenza agli antimicrobici è la capacità di un microrganismo di resistere all’azione di un antimicrobico. E’ diventato un problema sanitario europeo e mondiale sempre più grave sia per gli esseri umani che per gli animali, che limita o rende meno efficaci le opzioni di cura. Si tratta di un fenomeno naturale biologico di adattamento di alcuni microrganismi che acquisiscono la capacità di sopravvivere o di crescere in presenza di una concentrazione di un agente antimicrobico che è generalmente sufficiente ad inibire o uccidere microrganismi della stessa specie.
I batteri patogeni resistenti non necessariamente provocano gravi malattie rispetto a quelli più sensibili, ma la patologia, quando si manifesta, diventa più difficile da trattare, in quanto risulterà efficace solo una gamma ridotta di agenti antimicrobici. Da qui il decorso più lungo o una maggiore gravità della patologia, che in alcuni casi, può portare anche al decesso.
La progressione della resistenza antimicrobica può essere accelerata dall’uso eccessivo e/o inappropriato degli antimicrobici che, insieme a scarsa igiene e/o carenze nelle pratiche di prevenzione e controllo delle infezioni, crea condizioni favorevoli allo sviluppo, diffusione e persistenza di microrganismi resistenti sia negli esseri umani che negli animali.
Convegni, articoli, manifesti denunciano la situazione e sottolineano l’urgenza di un cambiamento di rotta: sono fornite indicazioni a cittadini, farmacisti e medici per un uso responsabile e appropriato di questi farmaci.
Ma c’è qualcosa che non convince
Le giornate o le settimane dedicate al tema appaiono solo celebrative quando non si realizzano azioni concrete per raggiungere gli obiettivi indicati: non c’è giorno del calendario che non sia rivolto alla lotta contro una o più patologie con risultati certamente non esaltanti.
Il problema dell’antibiotico resistenza è drammatico ed urgente e non va celebrato, ma va risolto.
Consigli e campagne sono rivolti ai cittadini, la cui responsabilità è modesta: va incoraggiato l’uso dei farmaci nelle dosi e nei tempi appropriati prescritti dal sanitario, ma non è certo loro responsabilità se possono acquistarli anche senza ricetta medica. Il punto centrale, senza valutare l’operato dei veterinari, è legato all’azione dei medici che sanno bene che gli antibiotici non sono necessari per:
1- infezioni delle prime vie respiratorie,
2- per batteriuria asintomatica,
3- nelle profilassi per le estrazioni dentarie e
4- nella profilassi perioperatoria prima dei 60 minuti e oltre le 24 ore dall’intervento.
Eppure, la pratica quotidiana è diversa, tanto che Slow Medicine e Altroconsumo nell’ambito del progetto “Fare di più non significa fare meglio – Choosing Wisely Italy” hanno messo a punto il Manifesto “Antibiotici, meno e meglio”, rivolto anche ai medici perché si impegnino a non prescrivere antibiotici in queste circostanze. Il Manifesto ha avuto il patrocinio del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore di Sanità e di FNOMCeO, nonché il supporto di 16 società scientifiche di medici, infermieri, farmacisti e veterinari.
I medici prescrivono antibiotici inutilmente anche perché:
È ancora diffusa la convinzione che ad un’infezione virale potrebbe far seguito una sovrapposizione batterica, e che l’antibiotico terapia sia in grado di svolgere un ruolo profilattico.
Il carico di lavoro dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta nei periodi epidemici è tale da non potersi permettere consigli di vigile attesa sull’andamento della patologia in atto, con il rischio di dover visitare più volte lo stesso paziente.
Nell’incertezza della diagnosi, nessuno contesterà al medico una prescrizione in eccesso, ma tutti lamenteranno una prescrizione in meno.
Non c’è più il tempo di rispettare i tempi del decorso della malattia; si richiedono terapie nella convinzione di accelerare i tempi di guarigione, e l’assenza di tempo da parte del medico per fornire informazioni corrette induce alla scorciatoia della prescrizione inutile.
La pressione prescrittiva da parte dell’industria farmaceutica è costante e pervicace. Basti osservare come l’impiego della combinazione di amoxicillina+acido clavulanico sia molto superiore a quello della sola amoxicillina nelle tonsilliti da Streptococco, nonostante le raccomandazioni di tutte le linee guida. Per questo motivo la sottoscrizione del Manifesto sopra citato da parte di alcune società che ricevono finanziamenti da parte di aziende produttrici anche di antibiotici indebolisce la credibilità dell’iniziativa. Una sana politica di assenza di conflitti d’interesse potrebbe essere un buon punto di inizio per modificare le prescrizioni inappropriate.
Note:
1 http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1448&area=veterinari&menu=antibiotici
http://www.assis.it/antibiotico-resistenza-ai-conflitti-dinteressi/?fbclid=IwAR3J3q_gZsX8y_wvL7FpaE97GOnQaF-dinJtPenHEnkuDddCjOyZxKIRp8A